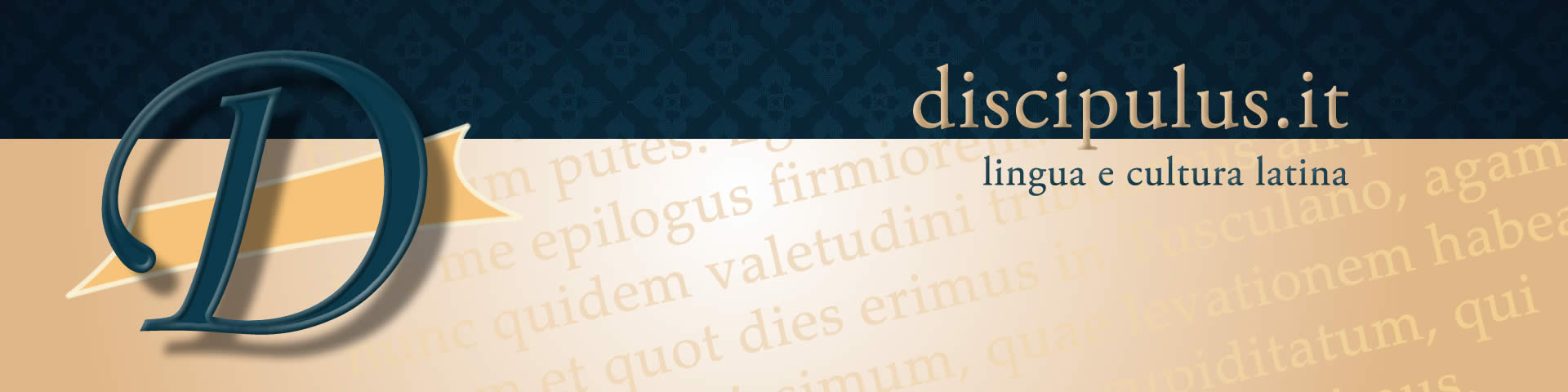@Francy wrote:
… se adesso mi pongo delle domande semplicissime, non so rispondere.
La difficoltà sta nel fatto che questo è latino arcaico; vedrai che con Virgilio non ci saranno tutti questi problemi, per fortuna. 😉
@Francy wrote:
òva parìre solèt genus pènnis còndecoràtum
In genus c’è la -s caduca o devo considerare -us breve?
Mah! Se provo a leggere, il ritmo mi suggerisce di ignorare la -s finale di genus, quindi credo sia caduca.
@Francy wrote:
fràxinus fràngitur àtq(ue) abiès constèrnitus àlta
Pìnus pròceràs pervòrtunt òmne sonàbat
àrbustùm fremitù silvài fròndosài
Mi sembrano tutti a posto; per l’ultimo verso vedi pagina 6 del seguente pdf
http://web.tiscali.it/alphaomega/Let_lat.pdf
@Francy wrote:
Perché la us di fraxinus è breve e quella di pinus, al verso dopo, lunga?
La us finale può essere sia breve che lunga o c’è un motivo a me ignoto?
Ho letto in rete che -us a fine di parola è generalmente breve.
Il punto non è tanto che -us sia generalmente breve (nella IV decl. infatti è lungo), quanto la frequente tendenza della -s finale a cadere.
Ho spulciato un mio libro molto tecnico, tutto impolverato 😀 , e ho trovato un saggio di Cesare Questa, riferito alla metrica latina arcaica, dove si dice che il fonema -s può, non deve cadere davanti ad iniziale consonantica, ma solo dopo vocale breve e mai nei monosillabi. Aggiunge che questo fenomeno è accettato in pieno dalla poesia esametrica di Ennio 😉 ; dice che non c’è alcuna norma precisa per l’elisione di -s, ma che all’orecchio il fenomeno è avvertibile solo dove il metro ci obbliga ad avere sillaba breve, così come siamo sicuri che non viene elisa dove il metro ci obbliga ad avere sillaba lunga.
Il resto alla prossima puntata 😀