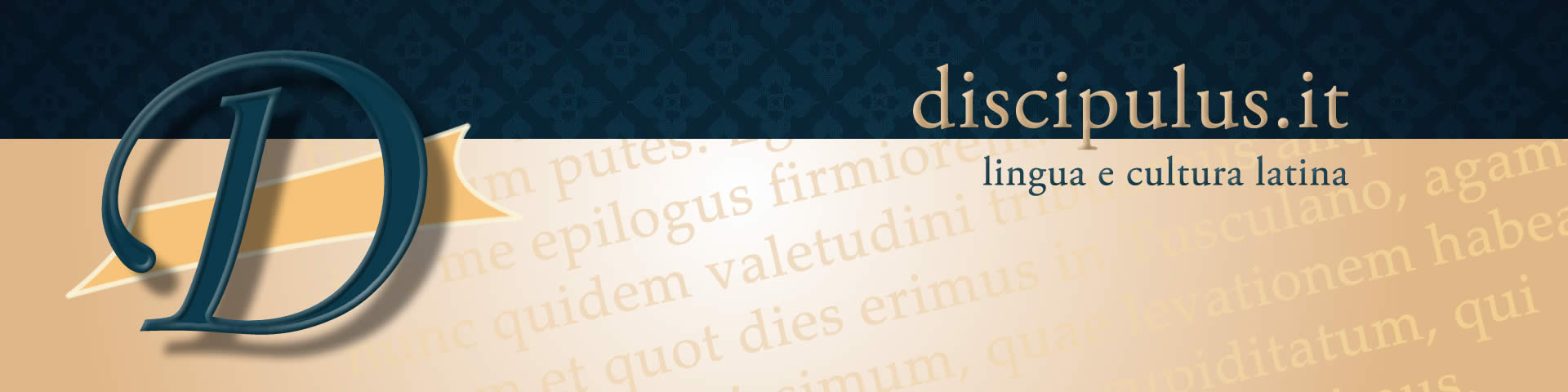- Questo topic ha 6 partecipanti e 7 risposte.
-
AutorePost
-
4 Febbraio 2009 alle 15:15 #11537
imported_Peppone
PartecipanteQualche giorno fa parlavo con un mio amico, il quale mi fece notare che nel nostro dialetto manca il tempo futuro, che è sostituito dal presente. Facendo qualche rapida ricerca su internet ho visto che anche altri dialetti, specialmene del meridione, non hanno forme per il futuro e perciò al suo posto si usa il presente.
C’è da dire che l’idea del futuro viene spesso resa utilizzando il verbo avere, a cui però non è sempre riconducibile una idea di necessità e doverosità.
Mi chiedevo a questo punto perchè non c’è nel dialetto il futuro?
Cercando in rete ho trovato una breve spiegazione di questo fenomeno a proposito del dialetto siciliano. Ricito una citazione che ho trovato nella mia ricerca:Asserisce in proposito Paolo Messina: < Come si può interpretare ( quasi filosoficamente ) questa anomalia? Ecco lo spunto per un nesso fra lingua e cultura, modi di essere e di pensare. E’ la consapevolezza storica dell’esserci heideggeriano a produrre la riduzione continua del futuro a presente, all’hic et nunc, e ciò nel pieno possesso del passato ormai definitivamente acquisito.
I siciliani sono padroni del tempo o, per dirla con Tomasi di Lampedusa, sono Dei.
Ma essere ( o ritenere di essere ) padroni del tempo può voler dire dominare mentalmente la vita e la morte, avere la certezza della propria intangibilità solo nel presente, un presente che si appropria del tempo futuro per scongiurare la morte, ombra ineliminabile dell’esserci. Quello che conta è il presente. Essere e divenire, insomma, nell’ansia metafisica si fondono o si confondono. >Quanto scrive tale Messina è un suo pio pensiero, ma che a mio avviso è un po’ troppo ragionato!
E nei dialetti di voialtri discipuli il futuro c’è? 🙂
4 Febbraio 2009 alle 16:37 #13018imported_Sempronia
Partecipante@Peppone wrote:
C’è da dire che l’idea del futuro viene spesso resa utilizzando il verbo avere, a cui però non è sempre riconducibile una idea di necessità e doverosità.
Anche nel mio dialetto il futuro non si usa e “devo fare” suona aja fa’, che penso sia da ricondurre al latino “habeo faciendum”. Per altro, i Siciliani dicono proprio aju a fari, dove è più evidente la traduzione del gerundivo latino.
Infine anche in greco εχειν + infinito, dal significato di “essere in grado di..”, slitta nella posteriorità a “dovere…”4 Febbraio 2009 alle 18:50 #13019Ptolemaios
PartecipanteIn bolognese c’è. A proposito di futuro, io sarò un po’ fuori di melone ma in italiano a volte sento l’esigenza di un congiuntivo futuro, più raramente anche di un condizionale futuro. 😮
4 Febbraio 2009 alle 21:40 #13020Artorius
Partecipante@Paolo Messina wrote:
Come si può interpretare (quasi filosoficamente) quest’anomalia?
@Peppone wrote:
Quanto scrive tale Messina è un suo pio pensiero, ma che a mio avviso è un po’ troppo ragionato!
😀 Sono d’accordo. Riporto quanto scrive Luca Serianni a proposito dell’origine del futuro in italiano e del condizionale in dialetto, sperando possa essere utile.
@Luca Serianni, in Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, capitolo XI, wrote:42. È importante osservare che avere ha svolto funzioni di ausiliare anche storicamente, contribuendo alla formazione di due tempi semplici: il futuro e il condizionale. Il futuro italiano — come in gran parte delle lingue romanze — non è altro che una perifrasi formata dall’infinito e dal verbo latino habeo ‘ho’ nella variante ridotta latino-volgare *ao (*sentire-ao propriamente ‘ho da sentire’ >sentirò). Il condizionale muove da una perifrasi costituita dall’infinito e dal perfetto latino habui ‘ebbi’, anche qui nella riduzione latino-volgare *ei (*sentire-ei>sentirei).
43. Nell’italiano antico e nei dialetti moderni è assai diffuso un tipo parallelo di condizionale, composto dall’infinito e dall’imperfetto latino habebam ‘avevo’, nella forma ridotta *ea(m) (*sentire-ea(m) >sentirìa). Attraverso l’influsso della poesia siciliana — in cui il condizionale in -ìa era usuale — questo tipo verbale penetrò nella lingua letteraria (limitatamente a 1a, 3a e 6a persona), persistendovi a lungo. Per esempi di sarìa e avrìa, i tipi più comuni, cfr. XI.59 e XI.67. Qui citeremo farìa («le parole morte / farian pianger la gente» Petrarca, Canzoniere, 18 12-13), vorrìa («altro vorria e sperando s’appaga» Dante, Paradiso, XXIII 15) e ancora schiuderìa nel melodramma dell’Ottocento («Mi schiuderia la tomba / affanno sì crudel!» S. Cammarano, Luisa Miller, in VERDI-BALDACCI 1975: 228).6 Febbraio 2009 alle 14:54 #13021imported_Dionisius
PartecipanteQui è Dionisius, in diretta dall’alta Lombardia.
Dopo aver interrogato con pazienza madri, padri e nonni, possiamo asserire che qui di futuro non c’è traccia.
Dopo le mie ricerche, ho riscontrato:
– g’ho da far + avverbio di tempo per l’area varesotta (madre)
– am a fa’ per l’area mantovana (padre)Qui è tutto, a voi la linea.
7 Febbraio 2009 alle 12:14 #13022Romano
PartecipanteNel dialetto lodigiano il futuro esiste.
Cito soltanto,Dué = dovere
mì duarò = io dovròVuré = volere
viàltri vurarì = voi vorrete.Diverso il discorso per il gerundio, praticamente scomparso e sostituito da locuzoni o altre perifrasi (nel girà / intànt che ‘l gira = girando).
7 Febbraio 2009 alle 14:45 #13023imported_Sempronia
Partecipante18 Marzo 2009 alle 20:48 #13024Romano
PartecipanteMi rendo conto di fuorviare un pochino la discussione ma in tema di dialetto lodigiano, mia zona di origine che amo tantissimo, mi è caduto l’occhio su questo articolo di oggi del quotidano “Il Cittadino” (di Lodi, appunto) e mi pare bello proporlo a coloro che amano la lingua e la cultura dialettale in genere
http://www.ilcittadino.it/ilCittadino/Articolo/tabid/277/Default.aspxSpero di non tediarvi con questo piccolo spunto sul dialetto. L’attenuante potrebbe essere che Lodi ha un passato romano, Laus Pompeia, in onore del console romano Gneo Pompeo Strabone (89 a.C.).
Buona lettura 😉
-
AutorePost
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.