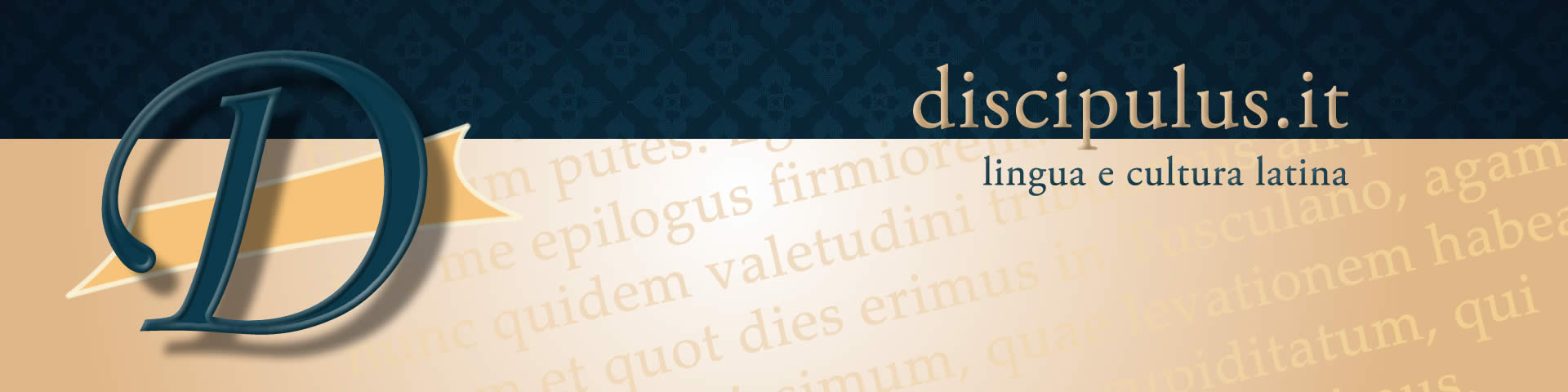- Questo topic ha 1 partecipante e 0 risposte.
-
AutorePost
-
4 Febbraio 2011 alle 22:26 #11745
imported_Peppone
PartecipanteSalve Discipuli!
Vi propongo un articolo di Luca Canali apparso oggi sul Fatto Quotidiano che ho trovato interessante e pertinente con questo forum. Ciao a tutti!ANTICHI BERLUSCONES: CORRUZIONE E LUSSURIA: COME ERAVAMO
Inquietanti analogie tra quello che riferiscono gli storici sulla
decadenza dell’impero romano e l’epoca attuale. Vita quotidiana di
imperatori viziosi – di Luca CanaliBasso impero e Tardo impero sono sinonimi, ma di solito “Basso
impero” è l’espressione preferita, forse per influsso di
quell’aggettivo “basso” che suggerisce anche l’idea di una “bassezza
morale”, laddove essa significa semplicemente la fase decrescente di
un soggetto storico prima in ascesa.In tal modo prende sempre più corpo l’idea d’una decadenza che invece
può anche non verificarsi o essere rimandata in secoli a venire.
Comunque lo spartiacque fra queste due fasi storiche dell’impero
romano può essere fissato al termine della dinastia Flavia, alla fine
del I secolo d. C (l’assassinio dell’imperatore Domiziano avviene nel
96 d.C.) durante il quale operano scrittori di prima grandezza, come
Giovenale, Marziale, Tacito, e il biografo Svetonio.E’ dopo di loro che si snoda durante quattro secoli, fra alti e bassi,
il periodo finale dell’Impero romano di Occidente, concluso nel 476
dalla vittoria finale del barbaro Odoacre sull’ultimo imperatore
romano, Romolo Augustolo.Non è solo una lunga agonia, perché alla guida della resistenza
“romana” si succedono imperatori di grandi capacità militari e
politiche (Massimino il Trace, eletto dai soldati durante il periodo
dell’anarchia militare del III secolo; Diocleziano, ideatore della
tetrarchia e spietato persecutore di cristiani; Costantino, che libera
tutti i culti religiosi: grande conquista dei Cristiani, che, prima,
arrestati, sottoposti a pene feroci, e persino suppliziati, ora
possono invece godere della libertà di culto passando addirittura alla
battaglia contro i loro nemici di ieri; Giuliano l’Apostata, che torna
alla religione pagana dopo essere stato a lungo cristiano; a seguire i
tre imperatori Valentiniano I, II, e III, impegnati in lunghe e dure
battaglie con popolazioni germaniche , e infine Teodosio il Grande,
imperatore cristiano, che fa addirittura del Cristianesimo la
religione di Stato.Ma, come ci eravamo proposti, cerchiamo ora consonanze della nostra
attualità con i grandi scrittori latini del II secolo d.C., che si
sono impegnati con risultati contraddittori nella lotta contro una
corruzione dilagante, di cui essi, consapevolmente o meno,
costituirono quasi uno specchio ustorio (come Giovenale), una beffarda
documentazione, o una gelida registrazione (Svetonio), o un
agghiacciante testimonianza (Tacito).Tra di essi, Giovenale può essere considerato il maggior scrittore
satirico di ogni tempo. Le sue satire mordevano la carne viva della
società di quel periodo di transizione rappresentato dalla
personalità, anch’essa venata di follia, crudeltà, libidine
dell’imperatore Domiziano, pur negli indiscutibili meriti militari e
sociali di questo secondo figlio dell’avvedutissimo amministratore
che era stato l’imperatore Vespasiano.Giovenale, modesto avvocato di provincia (era nato ad Aquino),
nella metropoli romana era costretto a vivere da cliens in mattutina
attesa di poter salutare, insieme ad altri disperati, il patronus che
ancora sbadigliando faceva distribuire loro la sportula contenente
cibi grossolani o avanzi del giorno prima, ugualmente necessari alla
sopravvivenza di quel gruppo di postulanti.
Era allora l’indignazione che faceva bruciare il fegato di quel grande
poeta, ma aveva il merito di ispirare i suoi versi: nisi natura facit
indignatio versus. Ed era quella indignazione a creare incredibili
scene di degrado morale che rappresentavano l’aspetto negativo di quel
dovizioso e insieme miserevole inizio del “basso impero”, nel quale i
disumani spettacoli circensi, il fanatismo sportivo delle folle e la
pratica di una letteratura basata sulla violenza e sul sesso estremo
(molto simile a quello della nostra attuale letteratura giovanile
postcannibalica).Si aggiungeva a tale quadro il disordine urbano, la congestione del
traffico, la cieca ostilità dei cittadini agli stranieri che
disponevano i loro banchi pieni di mercanzie di scarto, prugne secche
e fichi secchi, le matrone che gareggiavano fra loro nell’arte di un
erotismo senza freni, e vecchi prostituti, come Nevolo, che
lamentavano la propria laida professione insidiata da una concorrenza
spietata e sempre meno pagata. Leggere Giovenale è come una discesa
agli Inferi, senza alcun conforto o speranza.Altro aspetto della invivibilità di Roma, le lotte politiche e
sociali e nel Senato e nel Foro, di cui Giovenale ci fornisce una
documentazione spietata, dovendo però attingere il resoconto da
precedenti scrittori di satire (per esempio, Lucilio):E adesso, da mattina a sera, festivo o feriale / che sia il giorno,
popolo e senatori / si agitano tanto nel Foro e mai li trovi
altrove; / tutti ad arte occupati nell’unico e solo mestiere:
[…]gareggiare in finzioni, mascherarsi da onesti, / preparare
imboscate: tutti, insomma, nemici di tutti. (Satire, XXX, 4, vv.
1126-29; 1131-32)Certo i toni dell’oratoria politica antica sembrano a volte più
enfatici di quelli attuali, ma ciò è anche segno di una maggiore
capacità moderna di occultamento della sostanza delle cose, tendente
a personalizzare al massimo la polemica, evitando così di giungere al
cuore dei grandi problemi dell’intera nazione. Questo è costume di una
democrazia solo apparente, ove il potere, sempre in mano ai ceti del
privilegio, per mezzo di prezzolati ed esperti “persuasori occulti”
riesce ad addormentare e influenzare un popolo appagato da una certa
possibilità di consumi e diventato schiavo d’una massiccia
spettacolarizzazione della pubblicità, dello sport,
dell’informazione,e persino della bagarre parlamentare.In questo contesto, accogliendo una distinzione sociale resa
famosa dal nostro Umberto Eco, sarebbe giusto definire Giovenale, un
“apocalittico”; al contrario, il suo amico, il grande epigrammista
Marziale, potrebbe essere definito un “integrato”, il quale, pur con
la spregiudicata aggressività di alcuni suoi epigrammi, si conquista
da buon adulatore la simpatia degli imperatori Flavi, che in cambio
gli concedono lo ius trium libero-rum permettendogli di usufruire del
generoso sussidio previsto da questa onorificenza, anche se Marziale
non aveva mai avuto figli.Persino sinistramente sorridente è invece lo spettacolo di un altro
quadro, non più di infimo ordine, ma beffardamente borghese,
rappresentato con cinismo di alta qualità stilistica, da Marziale che
si avvale spesso di un espediente retorico di grande effetto, definito
fulmen in clausola , il quale consiste nel rovesciamento di senso e
di situazione nella conclusione di molti suoi epigrammi.Riproduciamone un paio ,scusandoci con il lettore per la spiritosa
oscenità di una scena:Ti piace bere tutta la notte, / Gauro: te lo perdono, / è un vizio
nobile, l’ebbe Catone. / E scrivi versi da offendere Apollo / e il
coro delle Muse: / meriti lodi, questo era anche il vizio / di
Cicerone./Sei goloso: ma è il vizio / di Apicio. Vomiti: / questo è il
vizio di Antonio. / Ma dimmi, chi te l’ha dato / quel vizio di
prenderlo in bocca? (Epigr., XI,104)Marziale non doveva amare Roma e quei tempi, tanto che in vecchiaia
si ritirò nella sua nativa Bílbili sfruttando la generosità e
l’ospitalità di una ricca vedova. Riscoprì allora la campagna come
luogo di riposo e contatto diretto con i semplici valori contadini.Lo testimoniano questi versi dedicati al poeta Giovenale: Mentre tu
forse, Giovenale, vaghi / inquieto per la chiassosa Suburra, / o sali
alla collina di Diana / e la toga ti ventila il sudore/mentre corri
ai palazzi dei potenti, / e ti stanca la ripida salita / del Celio, io
me ne sto / tranquillo a Bílbili,[…] Godo sonni infiniti,
profondissimi, / sino alle nove e più, / e mi rifaccio di tutte le
veglie / che per trent’anni ho sopportato a Roma. (Epigr., XII, 18)Questa breve documentazione d’una quasi filiazione del mondo
moderno da quello antico, si può concludere con una singolare
citazione di Svetonio, segretario privato di Traiano e archivista del
Palazzo imperiale, poi misteriosamente scomparso nel nulla.
Tale citazione riguarda l’imperatore Domiziano ed è breve, ma quel
ritratto d’insuperabile attualità ci riporta a personaggi e situazioni
di cui sono piene le pagine di quasi tutti i giornali attuali, non
solo italiani:Dava spesso banchetti lauti, ma brevi….Fu sommamente lussurioso, e
chiamava “palestra del letto” il frequente concùbito, quasi una
specie di esercizio ginnico; e si diceva che egli stesso depilasse le
sue concubine e sguazzasse tra le più divulgate meretrici. Dopo aver
insistentemente rifiutata la figlia vergine del fratello, che gli era
stata offerta in matrimonio, essendo egli coniugato con Domizia, la
sedusse poco dopo che era stata sposata a un altro.(Vita dei Cesari,
Domiziano,21,22) -
AutorePost
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.