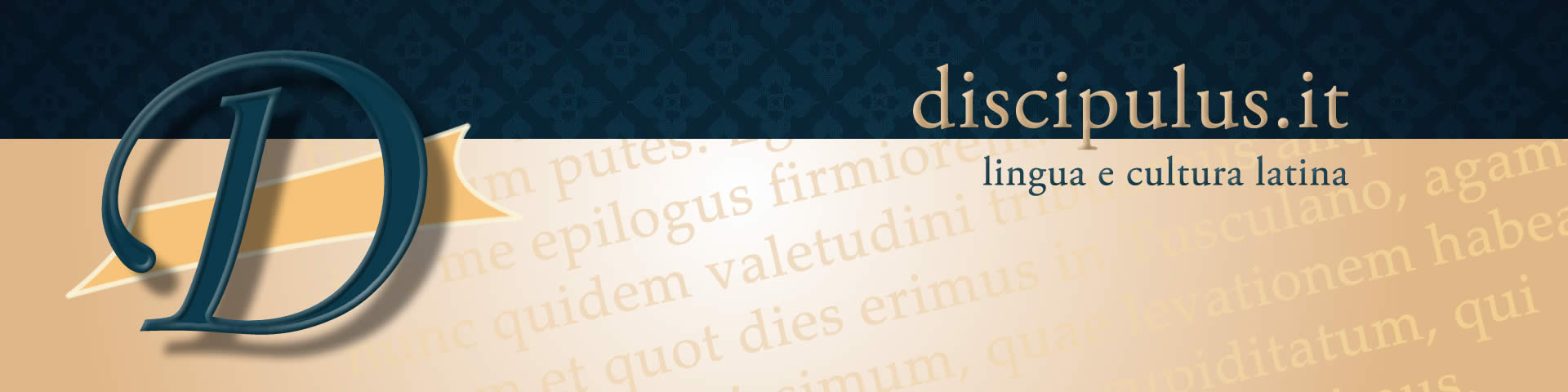Risposte nei forum create
-
AutorePost
-
24 Settembre 2009 alle 16:04 in risposta a: obiettivi e metodi efficaci nel latino: vostre esperienze #13581
Artorius
Partecipante@Hostilius_LXXXV wrote:
ma tutti i metodi alternativi a quello induttivo insegnati nei licei (che come già detto, non ho frequentato) non hanno anche loro l’obiettivo di arrivare a tradurre dal latino all’italiano?
L’obbiettivo principale del metodo induttivo-contestuale non è quello d’arrivare a tradurre dal latino all’italiano, ma quello d’arrivare a comprendere direttamente in latino: la traduzione è solo un ulteriore passo eventuale (per studenti avanzati). C’è una differenza sostanziale: i metodi tradizionali, invece, si propongono d’arrivare alla comprensione attraverso la traduzione, fin dall’inizio.
@Hostilius_LXXXV wrote:Nelle vecchie grammatiche che ho trovato si trovano perfino molti esercizi di traduzione dall’italiano al latino non come mezzo per comprendere la lingua ma come obiettivo fine a se stesso, quasi a voler dire che se sai scrivere in latino, sei più bravo di quelli che sanno scrivere solo in italiano!
Per le mie limitate conoscenze, non so ribattere a questa tua considerazione sui metodi tradizionali, ma dubito che tali esercizi fossero fini a sé stessi o concepiti per pura vanagloria: probabilmente c’era sempre la buona fede di voler portare a una miglior padronanza della lingua latina. Mi sembra di capire, comunque, che tali esercizi sian ormai quasi scomparsi dai manuali.
@Hostilius_LXXXV wrote:non mi sembra credibile che per quasi quarant’anni si fosse insegnato ai licei un metodo che non arrivava all’obiettivo della traduzione latino-italiano.
Ma, infatti, portava (e porta) proprio a quell’obbiettivo. La questione su cui si dibatte è con quanta efficienza lo facesse/faccia e se ciò comporti anche un pieno assaporamento del testo originale.
@Hostilius_LXXXV wrote:Tu parli “amore, dedizione e pazienza” ed eviti la parola “sacrificio”. Il problema è che queste affermazioni presuppongono che apprendere questa lingua sia qualcosa che gli studenti scelgono in modo consapevole perchè questo apprendimento è qualcosa di piacevole. Ciò però è contraddetto dal fatto che l’insegnamento del latino è obbligatorio in molti tipi di scuole superiori
Mi riferivo in special modo allo studente universitario. Alle scuole superiori, sta all’insegnante instillar negli alunni l’amor per la propria materia.
@Hostilius_LXXXV wrote:qualcuno affermerà “il latino è la lingua del diritto antico, della scienza, della medicina…” ma a queste cose basterebbero (come è stato fatto nelle mie scuole superiori) un bel po’ di lezioni nelle ore di italiano a imparare i vari prefissi e suffissi di origine latina e greca, non cinque anni di lingue classiche per arrivare a tradurre complessi testi letterari
Dipende: se ci si accontenta di prefissi e suffissi, bastano di certo i metodi da te esposti. Se, invece, si voglion leggere Cartesio, Copernico, Galileo, Hobbes, Newton, Spinoza, Vitruvio… direi che cinque anni di studio servono. C’è da aggiunger che solitamente, purtroppo, di prosa scientifica latina non se ne legge nemmeno ai licei scientifici. Ma a questo si può rimediare.
@Hostilius_LXXXV wrote:E questo non può che essere un male perchè secondo me è meglio che pochi per loro scelta e passione intraprendano un cammino di apprendimento faticoso, ma che alla fine dà i suoi frutti, piuttosto che molti, per obbligo e senza averne alcun interesse, intraprendano quello stesso apprendimento ma con risultati pessimi perchè il loro vero interesse era quello di diventare fisici, avvocati o veterinari senza passare per “nobili arti letterarie” che presuppongono un impegno inscindibile dalla passione per esse.
Non son d’accordo: forse non è la meta a esser inattingibile (se puntiamo alla comprensione e non all’arte della traduzione), ma il cammino a esser quello sbagliato. Non vedo perché a un fisico, un avvocato o un veterinario bisognerebbe precludere il piacere di tuffarsi nella saggezza degli antichi. C’è tempo all’università, per specializzarsi; a scuola bisogna piantar semi di saggezza in esseri umani che crescono.
23 Settembre 2009 alle 23:29 in risposta a: obiettivi e metodi efficaci nel latino: vostre esperienze #13579Artorius
Partecipante@Hostilius_LXXXV wrote:
Da quel che capisco mi sembra un metodo buono per gli autodidatti e buono anche per imparare molto vocabolario, ma noto che anche in quella discussione si è notato che per arrivare alla lettura di frasi complesse tipiche dei classici occorre molto tempo…
Non c’è da sorprendersi di questo: la lettura corrente dei classici è un obbiettivo di tutto rispetto e tutt’altro che facilmente attingibile. Basti pensare che quest’attività presenta difficoltà anche nella propria lingua madre, e che buona parte degli alunni che studiano latino non riescono a farlo neanche dopo cinque anni di studio.
@Hostilius_LXXXV wrote:In effetti avendo abbastanza calma potrebbe valere la pena spendere un po’ più di tempo per risparmiarmi di sfogliare il vocabolario troppe volte.
Vale tutta la pena di questo mondo! Le strutture grammaticali, con tutta la loro importanza e necessarietà, son pur sempre delle scatole: bisogna riempirle di contenuti.
@Hostilius_LXXXV wrote:Secondo me però anche in questi metodi c’è il difetto che si perde tempo perchè si pensa, oltre a come si comprende un testo latino, anche a come produrre testi in latino, operazione secondo me non indispensabile ai fini della comprensione di testi latini.
Secondo Luigi Miraglia (e molti altri esperti, immagino), l’uso attivo d’una lingua è utilissimo per arrivare a una piena comprensione passiva della stessa, oltreché addirittura indispensabile per poterne apprezzare le finezze retoriche e stilistiche. Nel metodo induttivo-contestuale/umanistico grande importanza è data al parlare e allo scrivere in lingua latina (e greca), e non per puro divertimento, non come obbiettivo, ma semplicemente come utile mezzo per giunger prima e meglio alla comprensione dei testi classici.
[Tieni conto che quanto scrivo non è farina del mio sacco — giacché io sono un mero studente ignorante — e che ti riporto il contenuto d’un’istruttiva lettura, che ti consiglio: Novā viā Latīnē doceō (guida per gl’insegnanti al metodo induttivo-contestuale), di Luigi Miraglia, appunto. Puoi scaricare il libro gratuitamente da qui. O meglio, potresti, ma il sito è attualmente in ristrutturazione e sembra non funzionar bene. Se sei interessato, hai due alternative: aspettar che risolvano, o farmi sapere il tuo indirizzo di posta elettronica, cosicché il libro te lo mandi io, che lo scaricai dalla vecchia versione del sito.]
@Hostilius_LXXXV wrote:mi viene il dubbio che il tempo di studio del comprendere le regole a partire dai testi si prolunghi molto di più rispetto a una più veloce enunciazione esplicita delle regole seguita dalle loro applicazioni.
Per come lo intendi, sí, è probabile che si prolunghi, ma dovrebbe valerne la pena: una più veloce enunciazione esplicita delle regole, seguita dalle loro applicazioni (cioè una decina d’esercizi ad hoc) difficilmente ti permetterà di ritenere a lungo quelle regole — e anche qui, non è farina del mio sacco, ma parlo per sentito dire. L’apprendimento d’una lingua è un processo lento e graduale: temo che non ci si possa aspettare di poterlo ottenere a schiocco di dita, ma che ci vogliano amore, dedizione e pazienza — nota che evito accuratamente la parola sacrificio, perché credo che (o credo di credere che 😀 ), se ci si deve sacrificare per farlo, o lo si sta facendo nel modo sbagliato o, forse, si farebbe meglio a qualcosa di piú piacevole. Provare piacere di quello che si studia, godere nell’apprendimento, è già un traguardo non indifferente.
@Hostilius_LXXXV wrote:le caratteristiche che richiedevo cioè con un metodo […] finalizzato solo alla traduzione latino-italiano
Eppure mi sembrava che tu parlassi di comprensione dei classici. Per comprendere un testo — come tu stesso saprai, se conosci bene una lingua moderna — non è necessario passare attraverso la traduzione. Anzi, è la traduzione a essere una nobile arte letteraria che necessita preventivamente della comprensione. Giungere alla comprensione (per poi, eventualmente, anche dedicarsi alla traduzione) è proprio l’obbiettivo del metodo induttivo-contestuale.
Artorius
PartecipanteNon posso mancar di fare anch’io gli auguri a un tale gentiluomo, che da quando ha il mio indirizzo non salta un Natale! 😀
22 Settembre 2009 alle 02:24 in risposta a: Lingue straniere per studiare la cultura classica #13597Artorius
PartecipanteCiao. 🙂
Posso provar a indovinare i titoli dei testi? Morphologie historique du grec di Chantraine? O forse Morphologie historique du latin, d’Ernout? Magari Syntaxe latine d’Ernout e Thomas o Syntaxe grecque d’Humbert? 😀 Non ho mai(/ancor) letto nessuno di questi testi, ma mi pare che siano piuttosto rinomati.
Se può esserti utile il mio inesperto parere, ritengo che valga sempre la pena di studiare una nuova lingua (o d’approfondirne una già conosciuta), se se ne ha il tempo: è come forgiarsi una chiave per innumerevoli e inimmaginate stanze del tesoro — perdona la metafora rudimentale. Conoscendo l’italiano (e il latino), raggiungere un livello di francese necessario ai tuoi scopi ti richiederebbe, credo, molto meno tempo che per il tedesco.
Anch’io ho sentito dir che il tedesco sia una lingua molto utile per chi affronta studi classici — certo, immagino, mai quanto latino e greco, che sono l’essenziale strumento per acceder alle fonti in presa diretta — ma probabilmente ci sono moltissime pubblicazioni interessanti anche in francese o in inglese.Artorius
PartecipanteQualora potesse esser utile, segnalo che il sito dell’Accademia Vivarium Novum è tornato in linea, rinnovato.
Al contempo chiedo scusa, perché non vorrei sembrarvi un promotore editoriale. 😛Artorius
PartecipanteAuguri! 🙂
Artorius
PartecipanteVita Moresque è un fascicolo aggiuntivo sugli usi e costumi dei romani. Approfondisce gli aspetti di civiltà accennati nei capitoli di Familia Romana.
Se posso permettermi, io consiglierei anche i volumetti d’esercizi (Exercitia Latina e Meletèmata), in special modo per il greco, giacché è proprio facendo uso del lessico che lo si fissa meglio.Artorius
Partecipante@Peppone wrote:
[…] quella pomposa retorica risorgimentale dell’inno di Mameli.
Anch’io lo valutavo come te, Peppone. 🙂 Poi ho letto questo articolo e mi sono un po’ ricreduto.
@Scudit wrote:Goffredo Mameli è un giovanissimo poeta e combattente (un eroe romantico?) che partecipa entusiasticamente alle battaglie di quegli anni.
Nel 1849 è a Roma, dove è nata la Repubblica Romana.
A Roma combatte al fianco di Garibaldi contro i francesi e, ferito ad una gamba, muore per la cancrena, all’età di 22 anni.
Il canto di Mameli-Novaro (noto con il nome di “Fratelli d’Italia”, dalle parole del primo verso) fu subito accettato dai giovani combattenti del Risorgimento come il loro Inno nazionale. Chiaramente a noi moderni il testo sembra molto retorico e la musica sembra una marcetta non troppo solenne, specialmente se suonata da una banda militare. Ma quel testo scritto di getto, spontaneo, appassionato e composto poi da un giovanissimo combattente per la libertà, sembrava il più adatto a simboleggiare la giovane Italia rivoluzionaria.Artorius
PartecipanteAuguri a entrambe! 🙂
Artorius
PartecipanteSic transit juventus! 🙂
Artorius
PartecipanteCi sono anch’io.
Mi ci trovo bene, tranne che per la scomoda la lista dei desideri, che non permette d’etichettare. Ho ovviato creando un’identità ad hoc.Artorius
Partecipante@Paolo Messina wrote:
Come si può interpretare (quasi filosoficamente) quest’anomalia?
@Peppone wrote:
Quanto scrive tale Messina è un suo pio pensiero, ma che a mio avviso è un po’ troppo ragionato!
😀 Sono d’accordo. Riporto quanto scrive Luca Serianni a proposito dell’origine del futuro in italiano e del condizionale in dialetto, sperando possa essere utile.
@Luca Serianni, in Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, capitolo XI, wrote:42. È importante osservare che avere ha svolto funzioni di ausiliare anche storicamente, contribuendo alla formazione di due tempi semplici: il futuro e il condizionale. Il futuro italiano — come in gran parte delle lingue romanze — non è altro che una perifrasi formata dall’infinito e dal verbo latino habeo ‘ho’ nella variante ridotta latino-volgare *ao (*sentire-ao propriamente ‘ho da sentire’ >sentirò). Il condizionale muove da una perifrasi costituita dall’infinito e dal perfetto latino habui ‘ebbi’, anche qui nella riduzione latino-volgare *ei (*sentire-ei>sentirei).
43. Nell’italiano antico e nei dialetti moderni è assai diffuso un tipo parallelo di condizionale, composto dall’infinito e dall’imperfetto latino habebam ‘avevo’, nella forma ridotta *ea(m) (*sentire-ea(m) >sentirìa). Attraverso l’influsso della poesia siciliana — in cui il condizionale in -ìa era usuale — questo tipo verbale penetrò nella lingua letteraria (limitatamente a 1a, 3a e 6a persona), persistendovi a lungo. Per esempi di sarìa e avrìa, i tipi più comuni, cfr. XI.59 e XI.67. Qui citeremo farìa («le parole morte / farian pianger la gente» Petrarca, Canzoniere, 18 12-13), vorrìa («altro vorria e sperando s’appaga» Dante, Paradiso, XXIII 15) e ancora schiuderìa nel melodramma dell’Ottocento («Mi schiuderia la tomba / affanno sì crudel!» S. Cammarano, Luisa Miller, in VERDI-BALDACCI 1975: 228).Artorius
PartecipanteMille grazie, gentil Peppone.
C’è un aspetto che non mi è ancora chiaro, però:
@Peppone wrote:Mi spiegò il Major che questo succede solo col primo commento che un utente effettua.
Per utente intendi indirizzo di posta elettronica, giusto? Te lo chiedo perché non sono stato in grado di commentare tramite la mia utenza del forum.
-
AutorePost